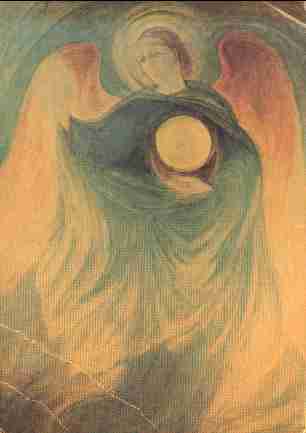 M. Woloschina: "Arcangelo Gabriele"
M. Woloschina: "Arcangelo Gabriele"Psicoterapia e autocoscienza
di Massimo Rinaldi
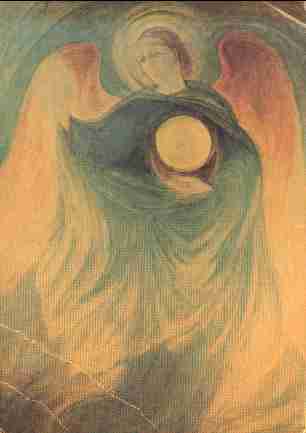 M. Woloschina: "Arcangelo Gabriele"
M. Woloschina: "Arcangelo Gabriele"
|
Chi di noi non è cosciente di se stesso? Esiste forse un essere umano che non sa di essere? No, certamente non esiste, fatte salve le gravi patologie psichiche, e i bambini nella primissima fase della vita. Già nel corso del secondo anno di vita compare questa facoltà tipicamente umana, che consente all'individuo di riferirsi a se stesso dicendo "Io", e che chiamiamo autocoscienza. Si tratta di qualcosa di più della semplice coscienza: all'inizio il bambino inizia a prendere coscienza del suo ambiente e dopo poco sa già della mamma, degli altri familiari, del seno o della pappa, degli oggetti che lo circondano, e anche molte cose di sé e della propria presenza, e parla di sé in terza persona, poiché non è ancora in grado di stabilire l'identificazione del soggetto pensante che lui è con quell'oggetto particolare che gli appare, non dinanzi ma molto più vicino delle altre cose, e che gli dà sensazioni a getto continuo: il proprio essere, intrinsecamente connesso al proprio corpo (in altri termini, il proprio "corpo delle sensazioni" connesso al proprio corpo fisico). Verso i due anni di vita, il bambino inizia a dire "Io" a se stesso, mostrando di aver sviluppato la prima forma di coscienza di sé, attraverso la riunione, l'identificazione di tutte le sensazioni e percezioni di sé con il proprio centro pensante. Da questa identificazione nasce la coscienza di sé, o autocoscienza, che è una forma di coscienza di livello superiore rispetto a quella dell'esistenza del resto del mondo. Se l'autocoscienza è già in possesso di ogni essere umano, fin dall'infanzia, perché parlarne ancora e interrogarci su di essa e, ancor più, sul suo rapporto con la psicoanalisi? In questa ottica, anche il noto comandamento rivolto nell'antica Grecia dal dio Apollo all'uomo: "Conosci te stesso", sembrerebbe un prurito di antichi filosofi con molto tempo da perdere. Affermava Goethe (in un suo scritto minore, rivolto alla metodologia della scienza): "Il grande e altisonante comandamento conosci te stesso mi è sempre parso come un astuzia di sacerdoti, segretamente in combutta per confondere l'uomo con pretese irrealizzabili e deviarlo dall'attività nel mondo esterno verso una falsa contemplazione interna" (J. W. Goethe, "Deciso impulso di un solo giudizio acuto", Opere, VolumeV, pag 57, Sansoni - Firenze, 1962). Sembrerebbe proprio, da queste autorevoli parole, che lo sforzo di sviluppo dell'autocoscienza non vada neppure tentato, perché il farlo risulta inutile o dannoso! Ma non è così: tra poco vedremo che Goethe intendeva parlare del modo di giungerci, non dell'autocoscienza in se stessa. In realtà, l'autocoscienza non è una qualità "tutto o niente": o conosco tutto di me e dei miei rapporti col mondo, o non so neppure di esistere. La prima forma di autocoscienza, quella che lampeggia già nel bambino, ci fa confusamente comprendere che noi siamo, ma non ci consente ancora di capire chi siamo, come siamo e quali siano le nostre qualità e quali i nostri difetti e debolezze, e ancora di più è difficile rispondere alle domande profonde sull'essere, se siamo immutabili o in evoluzione, se la nostra anima è immortale o è destinata a perire con il corpo, quali forze si affollano nel nostro animo, che cosa in noi è generalmente umano, qual è il nostro vero Io. Se la lista delle domande possibili è lunga, ancora più lungo è il cammino che un uomo deve fare, per poter dire di conoscere se stesso. Filosofie, religioni, correnti mistiche di tutte le epoche hanno cercato di rispondere in modo soddisfacente proprio a queste domande. Oggi è arrivato il momento della ricerca personale, perché l'uomo moderno rifiuta di affidarsi alla rivelazione altrui. Possiamo forse non trovare le risposte, ma non possiamo rinunciare a porci quelle domande, e a cercare di rispondervi. Non sarà pertanto superfluo leggere come prosegue Goethe: "L'uomo conosce se stesso nella sola misura in cui conosce il mondo, del quale ha coscienza soltanto in sé, come ha coscienza di sé soltanto in esso. Ogni nuovo oggetto, osservato bene, dischiude in noi un nuovo organo"(Id.). Dunque, l'autocoscienza, per Goethe, passa per la scienza e ne è un effetto collaterale. L'attività di ricerca esterna accresce l'interiorità umana, fino a "dischiudere nuovi organi" dell'anima. Mentre l'auto-contemplazione produce una falsa immagine di sé. Difficilmente si può contraddire questo assunto goethiano, poiché sappiamo quanto ciascuno di noi possa ingannarsi circa le proprie qualità, tendendo a vedere tutto atttraverso lo specchio deformante della propria anima: desideri, paure, ideali, ambizioni, complessi, pregiudizi non ci consentono di accettare serenamente le scoperte che possiamo compiere sul nostro carattere, sui nostri limiti, sui nostri difetti, a volte persino sulle nostre qualità. Questo dunque ci porta al problema della oggettività nella conoscenza di sé e al valore del percorso psicoanalitico. Ancora Goethe ci aiuta ad andare avanti: "Ma l'impulso maggiore ci viene dal prossimo, che ha il vantaggio di poterci comparare col mondo dal suo punto di vista e perciò raggiungere di noi una conoscenza più vicina di quanto non sia possibile a noi stessi. Perciò, negli anni maturi, ho sempre attentamente osservato fino a che punto gli altri potessero conoscermi, per venire più in chiaro su me stesso e sulla mia natura, in loro e su di loro, come in altrettanti specchi. (Id.)" L'intuizione di Goethe ci chiarisce dunque il valore della psicoanalisi e delle altre forme di psicoterapia nel percorso dell'autocoscienza. Lo psicoanalista (o, se si preferisce, lo psicoterapeuta) deve fare da specchio al paziente, restituendogli le osservazioni oggettive su di sé e sulle sue caratteristiche esistenziali, la cui percezione sarebbe altrimenti, come sempre è nella vita ordinaria, distorta dalla mancanza di punti di confronto tra l'interno e l'esterno, fenomeno a cui ciascuno di noi va soggetto quando osserva se stesso. Quando la psicoanalisi nacque e si sviluppò nelle sue varie forme, con Freud prima, e Jung, Adler, Reich e tutti gli altri poi, non le erano estranei questi obiettivi: la presa di coscienza è il cardine attorno a cui ruota l'intero percorso terapeutico psicoanalitico, con il conseguente processo di trasformazione del rapporto tra l'Io e le altre istanze psichiche. La presa di coscienza è il presupposto per la risoluzione dei conflitti inconsci che, proprio in quanto inconsci, hanno il potere di provocare scompensi emotivi e disturbi di vario genere. "Dove è l'Es, lì sarà l'Io", enuncia una massima freudiana che ben sintetizza questo concetto. Questo è stato l'elemento dirompente, il vero valore della provocazione freudiana al mondo scientifico dell'epoca. E proprio per ciò, l'intero movimento psicoanalitico si qualifica come strumento al servizio dell'emancipazione dell'uomo dalla necessità dei meccanismi psichici, degli istinti, dei complessi e per il raggiungimento della libertà dello spirito nella coscienza, nel rispetto di questa sua evidente linea evolutiva. Fin qui, gli aspetti che accomunano le psicoterapie di tipo analitico. Tuttavia, le differenze tra le varie scuole non sono piccole. L'accento, nel corso di una psicoterapia analitica, può essere messo su vari aspetti della vita interiore.Ad esempio, un'eccessiva concentrazione sugli aspetti affettivi dei rapporti pregressi del paziente con i propri genitori, come avviene talvolta nella pratica freudiana, apporta alla crescita dell'autocoscienza un contributo inferiore che non un esame più vasto che lavori prevalentemente sugli atteggiamenti presenti e e sulle prospettive future, come piuttosto operano tanto la psicologia analitica junghiana quanto, in genere, le psicoterapie a caratterizzazione umanistico-esistenziale (una citazione speciale merita qui la pur poco diffusa psicoterapia ad orientamento antroposofico, o steineriano). Dunque, una psicoterapia orientata in modo ampio e attenta a tutti gli aspetti della vita interiore sarà senz'altro più consona allo scopo dell'approfondimento dell'autocoscienza che non un percorso riduzionisticamente centrato solo su alcuni aspetti della vita interiore, siano essi quelli emotivi (come nella psicoanalisi tradizionale) o quelli cognitivi (come nella psicoterapia cognitivista). Una psicoterapia, cioè, che, accanto alla vita delle pulsioni, dei desideri, dei bisogni, delle paure, dei sogni, delle illusioni, delle speranze, delle delusioni sappia rivolgersi alla vasta gamma di inclinazioni, aspirazioni, ambizioni, aneliti, scopi, intenzioni, ideali, valori. La via dell'autocoscienza, in altri termini, passa per una psicoterapia che sappia comprendere ed accogliere, per portarli a sviluppo, tutti gli aspetti emotivi, sentimentali, cognitivi, volitivi della vita dell'anima, nei suoi risvolti corporei, psichici e spirituali. Articolo pubblicato su www.psicologiaonline.it |